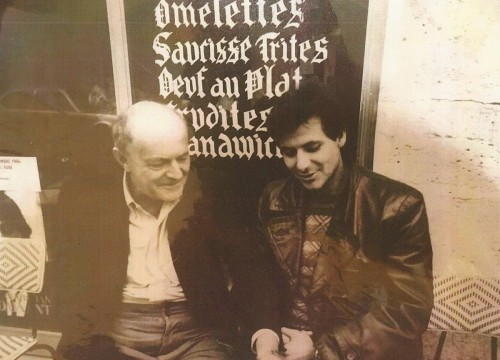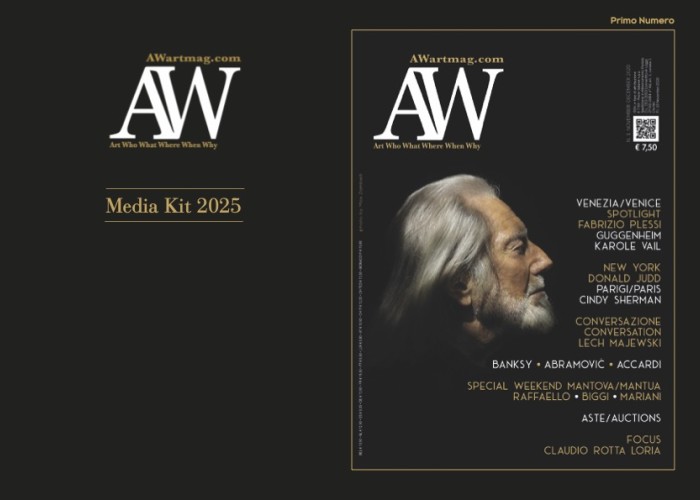Foreigners Everywhere: il titolo della 60ª edizione della Biennale. Non una grande novità per una città come Venezia, con una storia millenaria di apertura allo straniero. Basta guardare l'architettura di questa Costantinopoli occidentale, dove il gotico fiorito del Nord si armonizza con i losanghe e le cupole dorate di Bisanzio e dell'Islam. Nei secoli è stata crocevia di popoli e culture che nella Serenissima hanno trovato un'accoglienza curiosa, intelligente; un po' ladra di idee a volte, di opere e merci quasi sempre. Il brasiliano Adriano Pedrosa, curatore di quest'anno, doveva arrivare a proporre ciò che noi veneziani abbiamo nel nostro DNA.
E allora armiamoci di scarpe comode, pazienza, cortesia d'animo e andiamo alla festa. Ai Giardini, alle Corderie, tra ricevimenti esclusivi nei palazzi patrizi e spritz in spazi underground fatiscenti, la laguna esulta ovunque e l'atmosfera è elettrizzante. Come sempre, nei tre giorni dell'anteprima. Incontriamo la solita varia umanità che popola l'evento, persone che vanno a vedere le mostre piuttosto che a farsi vedere (e fotografare) alle mostre. Il solito chiacchiericcio, cinguettio, entusiasmo simulato, o altrettanto simulata indignazione. Ognuno recita la sua parte nel grande circo dell'evento internazionale d'arte contemporanea più importante. Il tema dello straniero è intrigante di per sé, se solo lo sguardo del direttore delle arti visive fosse riuscito ad andare oltre le mode del momento.
Anziché ancorarsi alla parola queer di tendenza, forse un riferimento all'Ulisse di Omero - uno straniero in terre straniere - avrebbe aiutato ad ampliare la visuale. Ci saremmo accontentati di un richiamo - in omaggio alla città che ospita l'evento - a un altro grande viaggiatore in terre sconosciute come Marco Polo, a 700 anni dalla sua morte. No. Avremmo anche apprezzato, dopo 123 anni dalla nascita della psicoanalisi, un ulteriore approfondimento sul concetto che in fondo ciascuno di noi, a causa dell'inconscio, è straniero in primo luogo a se stesso. Niente da fare. Qui, per esporre e vincere premi, i requisiti - nobili in teoria - sono: provenienza dal Terzo o Quarto mondo, appartenenza alle categorie dei marginalizzati, dei poveri, degli oppressi. Purtroppo, però, la pietas umanitaria di Pedrosa scivola nel conformismo dei non conformisti e vi si adatta. Per essere invitati alla sua biennale, sembra che si debba aver militato in collettivi, preferibilmente femministi. Necessario anche dichiararsi fluidi, strizzare l'occhio alle norme comportamentali LGBTQIA+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali).
La qualità artistica? Una gradita opzione, se capita. Prevalgono le dichiarazioni d'intenti: recriminazione anticolonialista, protesta in stile gay pride, o documentario, proposta di opere folk che sembrano provenire da artigianato Maori, Nigeriano o Carioca. Arazzi, ricami, patchwork vari, il cui valore è dato quasi esclusivamente dall'etnia, o dalle orientazioni sessuali non tradizionali di chi li ha realizzati. Tanto colore, tanta pittura - un valore se non fosse per lo più raffazzonata, approssimativa, carnevalesca. Ricorderemo questa edizione 2024, nel complesso, come una sfavillante Babele. Sì, stranieri ovunque, anche noi a casa nostra. Va detto che almeno il titolo, questo strano (o queer o che?) direttore l'ha azzeccato.