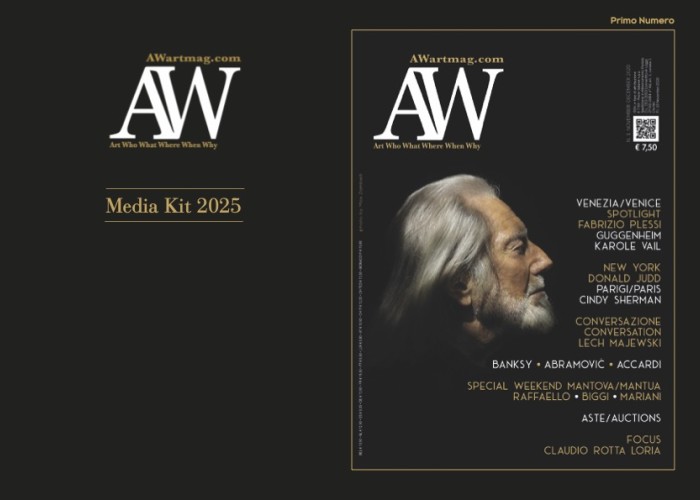La parola a Ida Panicelli: dirige Artforum dall’88 al ’92 portando alla rivista un pubblico più internazionale. Il lungo sodalizio con Germano Celant, per lei uomo moderno e rinascimentale assieme
Nella Roma dei primi anni ’80 (quella de La Tartaruga, de La Salita, de L’Attico, del Centro Jartrakor ed altro, ma anche di Giorgio de Marchis, direttore della Galleria nazionale di arte moderna, risoluto nell’intendere l’attività museale quale produzione culturale tra storia e contemporaneità), accadeva che Ida Panicelli, una giovane curatrice responsabile del dipartimento delle arti performative con New York nella testa e nel cuore (con permanenze/studio alla Columbia University nei primi anni ‘70), firmasse alcune mostre nodali tra cui “Arte Minimal. Carl Andre, Donald Judd, Robert Morris. Opere dalla collezione Panza di Biumo” (1980), “Fendi-Lagerfeld. 25 anni di collaborazione” (1984), “Arte e Critica” (1980) e “Arte e Critica” (1981). Va ricordato di quest’ultima (tempo e luogo del nostro primo incontro) il persistente rapporto critico- opera e i percorsi espositivi legati alla “risonanza estetica di ogni singola opera”, per dirla con Ida. Ed è proprio nel 1981, con articoli e recensioni dall’Italia e da New York, che la Panicelli inizia la sua collaborazione con “Artforum”, di cui sarà editor in chief dal marzo 1988 (immaginato, nel suo primo editoriale “come una casa, una casa abbastanza grande da accogliere le idee e le immagini di tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’arte contemporanea”) al giugno 1992. E da quel momento a tutt’oggi contributing editor.
Nel 1993, alla direzione del Museo Pecci di Prato, Ida lavora sul dialogo tra la realtà internazionale dell’arte e la complessità di quel territorio, e realizza una sequenza di fatti e di mostre, da “Inside Out” (1993) a “Gli ultimi sogni di Joan Miró” (1994), a “Fellini: i costumi e le mode” (1994). Seguono un decennale itinerare in India e nel sud-est asiatico tra note e servizi, ma anche, tra l’altro, la mostra di “Pat Steir” alla GNAM di Roma (2004), “Impermanence” il libro d’artista con Max Gimblett per le Edizioni Canopo di Prato (2016) e i saggi in catalogo per “Betty Woodman” a Palazzo Pitti a Firenze (2009) e per “Jene Highstein” al Laumeier Sculpture Park di Saint Louis, Missouri (2019). Ora, in attesa del nuovo numero di Artforum per leggere lo scritto della Panicelli su Joyce Kozloff, cui la rivista dedica anche la copertina, ecco quest’alternanza di domande e risposte che suole chiamarsi intervista.
"ERO CONSAPEVOLE DI AVER EREDITATO DA INGRID SISCHY UN MENSILE
DI PRESTIGIO GRAZIE AL SUO ISTINTO E ALLA COLLABORAZIONE CON GERMANO CELANT"
Cosa vuol dire aver diretto Artforum dal 1988 al 1992?
Quando ho iniziato a dirigere Artforum nel 1988, ero consapevole di aver ereditato da Ingrid Sischy un mensile di prestigio, che grazie al suo istinto e alla sua stretta collaborazione con Germano Celant si era aperto a campi contigui all’arte, come la televisione, il cinema e la moda, cavalcando le tendenze più d’avanguardia dell’arte americana, e creando intensi dibattiti nella metà degli anni ‘80. Il mio contributo è stato quello di aprire la rivista a un pubblico internazionale più vasto, portando attenzione non solo ad artisti, ma anche al cinema, teatro e danza in Europa; ricordo per esempio gli articoli su Almodovar, Strehler, Pina Bausch. Fin dal mio primo numero ho anche ampliato la presenza di donne artiste, che hanno contribuito con testi e progetti creati apposta per il magazine - come Louise Bourgeois, Nancy Spero, Pat Steir, Barbara Kruger, Guerrila Girls - non più solo come portatrici del verbo femminista, ma partecipando in prima persona ad una nuova analisi del sistema e dei linguaggi dell’arte. Il mio progetto sull’anniversario del ’68, scritto e ideato con Thomas McEvilley nel maggio 1988, è stato una sorta di dichiarazione di intenti; e da lì in poi la storia, la politica e l’impegno sociale sono diventati argomenti salienti negli articoli e negli editoriali del magazine. Con il contributo prezioso di scrittori e artisti, filosofi e critici d’arte abbiamo affrontato l’impatto con eventi di portata storica, dalla caduta del muro di Berlino alla guerra del Golfo, l’attacco dei Repubblicani alla libertà di espressione, e la drammatica realtà dell’epidemia di AIDS che stava devastando il mondo dell’arte. In quegli anni stava anche maturando la necessità di aprire alle diverse formulazioni delle culture non occidentali, con le loro legittime necessità di essere riconosciute, oltre l’ottica eurocentrica della storia. I testi di McEvilley e di Homi Bhabha sono stati pietre miliari del post-modernismo, aprendo una coscienza critica sulle relazioni tra l’Occidente e il resto del mondo.
Quale è stato il tuo rapporto con Germano Celant?
Germano Celant aveva il ruolo di contributing editor già con Ingrid Sischy, e ha impresso con lei una svolta determinante al magazine negli anni ‘80, dissolvendo le frontiere tra i linguaggi. Lei, consumatrice vorace del presente, lui capace di tessere le narrative contemporanee con la sua ferma posizione da storico dell’arte: insieme hanno fatto di Artforum uno specchio di quella vivacissima decade. Io avevo già lavorato con Celant al catalogo della mostra “Identité Italienne” al Centre Pompidou a Parigi nel 1981: esperienza formativa e esaltante. Averlo come contributing editor durante la mia direzione, dall’88 in poi, è stato un supporto enorme: Germano portava ogni mese nelle nostre riunioni di redazione il suo aspetto così rilevante della produzione del maestro. Le difficoltà di gestire uno spazio come il Pecci risiedevano all’epoca nel conflitto tra pubblico e privato, e la conseguente incertezza sulle capacità finanziare a disposizione. Ma anche nella limitatezza dei responsabili locali nel comprenderne la vocazione museale, come se non volessero credere fino in fondo alle reali potenzialità del Centro. Problema che mi sembra sia tornato violentemente a galla con la recente revoca dell’incarico di Cristiana Perrella dal ruolo di direttrice da parte di un consiglio d’amministrazione che sembra volgersi ad una visione del Centro Pecci come contenitore di mostre blockbuster, dimenticando le complessità e le necessità di una struttura museale.
E cosa ti rimane di lui?
Celant è stato un curatore sensibile, sempre attento ai bisogni degli artisti; un critico lucido e uno scrittore prolifico; così come un giocatore astuto nel mondo dell’arte internazionale. Una figura della modernità, e insieme un personaggio eclettico, un uomo rinascimentale. Un paradosso certo inimitabile. Mi rimane il ricordo della sua leggendaria biblioteca e archivio di Salita Oregina a Genova, dove ho avuto occasione di studiare fin da giovane; le varie installazioni di mostre in cui lo ho affiancato, godendo della sua capacità di mettere in relazione le opere, della fluidità delle sue scelte curatoriali. E ora, il rapporto affettuoso con suo figlio Argento, che mi restituisce di lui una parte intima e familiare molto tenera.
Quali le scelte nella direzione del Museo Pecci dal 1993 al 1994?
Già dalla prima mostra che ho curato al Pecci, intitolata “Inside Out”, ho voluto aprire il museo ad un dialogo con la città, con gli interventi nel centro storico di Kawamata, e il grande lavoro di Barbara Kruger sul muro della fabbrica di fronte al museo; per finire con la produzione dell’opera teatrale di Fabio Mauri “Cos’è il Fascismo” nell’anfiteatro del Centro Pecci. La città non si rivelò molto ricettiva, in realtà, ma questo era allora il limite di quella provincia italiana. La mostra dedicata a Federico Fellini, un anno dopo la sua morte, dove esponemmo i suoi costumi di scena accostati ad abiti ispirati ai suoi personaggi, disegnati dai principali stilisti internazionali, è stata invece l’occasione per coinvolgere gli industriali del territorio, ma anche professionisti diversi, da Giulia Mafai, storica del costume, al designer Massimo Vignelli, con cui ho ideato l’allestimento e il catalogo. È stata la mostra di maggior successo, ha viaggiato per alcuni anni in molti musei europei, e la ricordo volentieri, per la creatività che abbiamo profuso nel raccontare al pubblico in modo visivamente allettante un aspetto così rilevante della produzione del maestro. Le difficoltà di gestire uno spazio come il Pecci risiedevano all’epoca nel conflitto tra pubblico e privato, e la conseguente incertezza sulle capacità finanziare a disposizione. Ma anche nella limitatezza dei responsabili locali nel comprenderne la vocazione museale, come se non volessero credere fino in fondo alle reali potenzialità del Centro. Problema che mi sembra sia tornato violentemente a galla con la recente revoca dell’incarico di Cristiana Perrella dal ruolo di direttrice da parte di un consiglio d’amministrazione che sembra volgersi ad una visione del Centro Pecci come contenitore di mostre blockbuster, dimenticando le complessità e le necessità di una struttura museale.
Nell’era post Covid-19, come muta il ruolo di un museo d’arte contemporanea?
In questo anno e mezzo di sofferenza dei musei, nonostante i lockdown, abbiamo potuto continuare a frequentare virtualmente collezioni e mostre, grazie al web e ai social media, potendo persino stare al passo con la produzione degli artisti nelle viewing rooms delle gallerie private o delle case d’aste. Mentre l’offerta di arte online si allargava a livello internazionale, la limitazione frustrante di questa esperienza era senza dubbio il formato ridotto in cui tutto veniva fruito: lo schermo del computer, dell’i-pad o del cellulare, dove quadri sculture, installazioni o video venivano omologati in una medesima dimensione. Oggi il museo ha un richiamo ancor più forte, proprio perché il desiderio del corpo a corpo con l’arte si è fatto più impellente, dopo tanta mancanza ‘fisica’ dell’opera. Penso che il campo di intervento sia larghissimo, e anzi un’occasione imperdibile per rilanciare argomenti forti, che abbiano a che fare anche con le modificazioni della struttura sociale e culturale avvenute in questi anni. Ne è la prova la fila di visitatori al MAXXI di Roma nei giorni scorsi, dove è esposta “The Purple Line”, un’opera di Thomas Hirschhorn di forte impatto politico ma anche emotivo, e certo di non facile fruizione. Il coraggio di un direttore di museo visionario come Hou Hanru fa la differenza, e dimostra che l’arte contemporanea può lasciare il segno sulle coscienze.
CELANT IMPRIME ALLA RIVISTA UNA SVOLTA DETERMINANTE DISSOLVENDO LE FRONTIERE FRA I LINGUAGGI
In quale direzione va l’arte americana del XXI secolo?
Sono tornata a New York dopo circa due anni, non appena sono stata tolte le prime restrizioni. L’offerta di mostre museali era come sempre alta, con le retrospettive di Alice Neel al Metropolitan, e Julie Merethu al Whitney, e la straordinaria mostra “Grief and Grievance” ideata da Okwui Enwezor al New Museum. La presenza delle donne, degli artisti di colore o non occidentali è pervasiva, sia nei musei che nelle gallerie private. Negli ultimi anni si è sviluppata infatti una nuova consapevolezza, e si va verso una sempre più larga inclusione, cosa niente affatto scontata, dopo gli anni bui della amministrazione Trump. Purtroppo però, proprio a causa delle disastrose politiche di quei quattro anni, e della pressante disinformazione, si sono aperte fratture nel tessuto sociale e culturale, sotto forma di diffidenza, paura, ostilità e compromessi. In campo artistico, il caso peggiore è stato la sospensione della mostra di Philip Guston a Washington e in altre sedi internazionali, per timore delle possibili reazioni negative alla esposizione dei suoi dipinti in cui compaiono membri del Ku Klux Klan incappucciati. Temo quell’aspetto puritano della cultura americana, quel moralismo oggi diffuso, dopo lo tsunami liberatorio del movimento Metoo e BlackLivesMatter.
E in quale va, invece, l’arte italiana?
L’Italia arranca, purtroppo, nel panorama internazionale, e gli artisti faticano tanto quanto i giovani curatori e critici d’arte. Eppure nelle gallerie private e nei musei vedo sempre più artiste, giovani e non, che mostrano un interesse per i temi sociali, l’ecologia, il rispetto della natura, come Marzia Migliora, Federica di Carlo e Lulù Nuti. Questi anni di “fermo” hanno consentito agli artisti una benefica possibilità di lavorare e riflettere, di tentare nuove strade e di espandere gli interessi in media diversi. In pittura, con modalità stilistiche molto personali e previlegiando tematiche psicologiche, ho visto crescere Guglielmo Castelli e Romina Bassu. E mi hanno interessato le libere interpretazioni di fotografia e scultura di Monica Carocci, Corinna Gosmaro e Davide Monaldi. Un caso a sé è Alessandro Brighetti, che con i suoi Curanderos offre una risposta poetica alla necessità di guarigione in questi tempi dolorosi. Ho molta fiducia nelle nuove generazioni e do loro ascolto: nelle mie conversazioni con i giovani artisti sento un fermento che non c’era prima e che non ha niente a che fare con il mercato, ma con la voglia di ricerca individuale, di crescita personale. È un momento incredibilmente prolifico, che porterà nuove personalità alla ribalta dell’arte italiana.