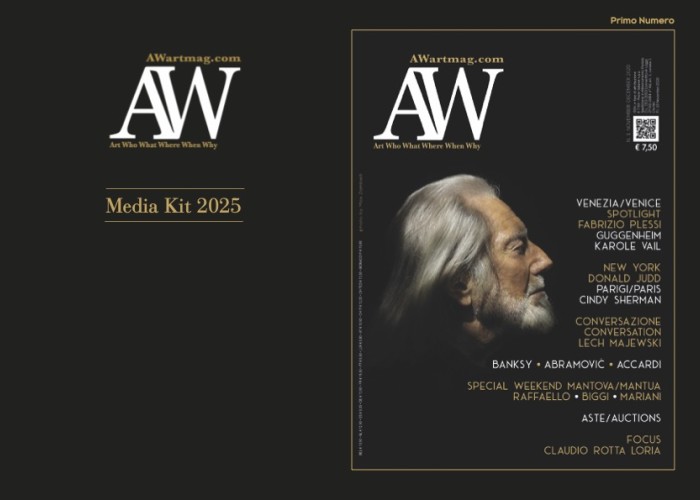Tutti in mostra alla mostra
C’erano una volta i globetrotter dell’arte. L’agenda fitta di una serie di must go verso i luoghi più ambiti dove si celebravano i riti della creatività contemporanea. Sempre in cerca dei vernissage più esclusivi, sempre a caccia di inviti, pronti a dare l’anima - qualcuno/qualcuna perfino il corpo - pur di far parte di quella selezionatissima schiera di eletti, che avevano ricevuto il grande onore di essere graditi ospiti ai ricevimenti più cool del momento. Una umanità stravagante e ciarliera, dal vocabolario ricco di wow e wonderful, a prescindere dalla lingua madre, assai solerte a osannare gli artisti già peraltro osannati dal sistema dell’arte internazionale. Era tutto un cicaleccio di frasi fatte, ripetute a pappagallo, delle quali loro per primi non capivano nulla. Del resto, lo sforzo della comprensione non era richiesto. Anzi. Vietato approfondire, porsi domande, pena venire bollati per guastafeste ed essere cacciati da tutti gli eventi futuri. L’importante per costoro era poter dire (a chi, poi?): io c’ero.
L’avvento dei social risolverà il problema. Ed eccoli riempire le pagine Facebook e Instagram con i selfie più improbabili. Eccoli, con espressione perlopiù beatamente ebete, immortalati accanto a Jeff Koons, Maurizio Cattelan, o Marina Abramovic, a loro volta in posa come divi hollywoodiani: una foto non si nega a nessuno, che diamine. Ecco i trottolini planetari accontentarsi di vivere di luce riflessa, talmente frivoli e superficiali da non rendersi nemmeno conto del loro angusto ruolo di comparse nel grande carrozzone del circo dell’arte. A Venezia per la Biennale, a Kassel per Documenta, a Basilea, Miami, Hong Kong per la fiera, a New York per le vernici al MoMA o alla Guggenheim, rivedevi ovunque le stesse facce estasiate, spesso assonnate per via del fuso orario, a cercare di esprimere, goffamente come improvvisati attori di provincia, un entusiasmo e una felicità d’obbligo, a cui i più onesti in fondo non credevano.
Li riconoscevi già in aeroporto, nelle stazioni, per le strade quelli della tribù delle mostre, per via del particolare codice di abbigliamento, che nelle loro teste sarebbe dovuto risultare originale e invece era solo esasperante mancanza di buon gusto. Abito scuro, ma con i calzoni ben sopra la caviglia, infradito, occhialetti dalla montatura in colori psichedelici: lui; scarpe di legno stile zoccoli di van Gogh, lugubri, ampie e lunghe gonnellone nere, camicie masochisticamente abbottonate fino alla gola: lei. Se qualcuno poi osava presentarsi alle feste accennando a una raffinatezza d’altri tempi, magari in smoking o con un sobrio abito da sera, diventava immediatamente oggetto dello scherno e delle critiche altrui, emarginato e trattato come un imbucato.
Ora, dopo un anno di isolamento forzato a causa del coronavirus, non ci verrà mica in mente di aver nostalgia di tutto ciò? Dicono: nulla sarà più come prima. Lo speriamo davvero.